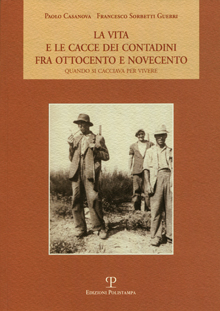Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Un libro racconta fame e miseria dei mezzadri tra Ottocento e Novecento
Non ce la facevano a campare, allora chiedevano soldi al padrone e per restituirli diventavano bracconieri Un affresco vivace e puntuale della società contadina toscana (ma anche dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria) tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale. Un mondo oggi scomparso, dove i rapporti tra contadino e proprietario erano regolati dalla mezzadria e dove fame e miseria erano le uniche regole di vita per chi coltivava la terra. L’affresco è quello che offre il libro “La vita e le cacce dei contadini fra Ottocento e Novecento - Quando si cacciava per vivere”, dei docenti universitari fiorentini Paolo Casanova e Francesco Sorbetti Guerri (Polistampa, pagg. 195, euro 16). Ne parliamo con Paolo Casanova. Professore, cominciamo dal titolo: chi cacciava per vivere? «Soprattutto erano i mezzadri, coltivatori diretti non proprietari che avevano avuto il fondo in concessione, tramite contratto di mezzadria, da un concedente. Queste forme di agricoltura potevano avere un qualche valore nelle zone fertili di pianura, nelle zone costiere e basso collinari, ma nelle zone montane questa agricoltura era solo di sopravvivenza e spesso non si riusciva neanche a sopravvivere con il raccolto. Di qui la necessità, da una parte, di cercare soldi per campare (quindi indebitamento con il proprietario) e dall’altra di cercare entrate che affiancassero quelle del podere. Siccome per contratto mezzadrile queste persone non potevano lavorare fuori dal podere senza il consenso del concedente, non rimaneva che la caccia per comprare quello che il podere non poteva fornire, come un paio di pantaloni, una giacca, l’aringa, il sale o lo zucchero». C’era differenza tra la miseria dei mezzadri toscani e quella dei contadini bergamaschi dell’“Albero degli zoccoli” di Olmi o quella dei contadini meridionali di Carlo Levi o Ignazio Silone? «La differenza esisteva nella gestione del territorio, ma non nel bilancio familiare. Il fattore comune era dato da scarse conoscenze tecniche, scarsi mezzi, bassi raccolti e insufficienza dei raccolti a fornire la base alimentare per la famiglia colonica per tutto l’anno, con la necessità allora di ricorrere alla caccia, spesso di frodo perché il costo delle licenze, con la legge del ’23, fu aumentato notevolissimamente. Mussolini cercò di troncare il bracconaggio, perché era arrivato al potere anche grazie all’aiuto degli agrari, di conseguenza la legge del ’23 penalizzò chi non aveva soldi, in particolar modo i contadini. Da quell’anno quasi tutti diventarono cacciatori di frodo, perché la legge aveva proibito determinati mezzi prima leciti e perché le tasse per licenza di caccia e porto d’armi non potevano assolutamente rientrare nel bilancio della famiglia contadina diretto-coltivatrice». Si lavorava tanto e si raccoglieva poco. Di qui la necessità di usare il più razionalmente possibile i pochi alimenti a disposizione. «Per forza. Si cucinava con quel pochissimo che c’era, cercando di inventare qualche cosa che più che altro riempisse lo stomaco, perché la cucina colonica era molto voluminosa e basata sulla fibra grezza delle verdure, ma come calorie e come proteine era molto povera. Erano popolazioni perennemente soggette ad una dieta ipocalorica e ipoproteica, tant’è vero che, se andiamo a vedere le misure biometriche alla visita di leva, le popolazioni rurali erano affette da rachitismo. Non per nulla dopo il miracolo economico la statura in Italia è aumentata». Nel libro si dedica molto spazio a descrivere la cucinal, sia come ambiente che come cibi. Colpisce l’ingegno con cui le donne utilizzavano quel poco che c’era. «È chiaro che non c’erano limiti di tempo per cucinare, perché la massaia in genere stava in casa, quindi poteva bollire tutto quello che voleva per il tempo che voleva, però era limitata dalla scelta, cioè dalla cucina colonica, che si basava soprattutto su verdure e in secondo luogo su carboidrati provenienti da quel poco grano del podere, su castagne e patate». Veniamo alle veglie serali. Erano gli unici momenti di socialità? «Sì, perché in genere c’era una conflittualità permanente tra le famiglie coloniche confinanti: i piccioni dell’uno erano andati a beccare nel campo dell’altro, le pecore avevano sconfinato, e così via. Non era affatto un mondo idilliaco». Quando però arrivava il giorno di festa... «Eh, sì, ogni tanto capitava il pranzone. Quando si vedeva la massaia che tirava il collo a qualche pollo, voleva dire che stava arrivando una festa e certamente la cucina diventava molto più ricca, anche per la presenza di paste farcite come tortellini, tortelli, ravioli e altro ancora». Il padrone che atteggiamento aveva verso queste cacce nascoste? «Se era un cacciatore, nasceva una sorta di complicità, purché il colono non diventasse un concorrente. Se non lo era, lasciava perdere, salvo la presenza della normativa prevista dalla legge del 1923 a cui mi riferisco costantemente, perché i guai causati dal fascismo, che noi paghiamo ancora oggi per quanto riguarda la gestione della fauna selvatica, vengono da quella legge che i governanti del dopoguerra non hanno modificato in modo radicale. Mussolini ha sempre appoggiato la caccia di massa, indipendentemente dalla possibilità delle popolazioni selvatiche di sostenere il prelievo venatorio. Ecco allora l’articolo 842 del Codice Civile Rocco che consente ai cacciatori di entrare nei terreni senza chiedere il permesso al proprietario. Una serie di abitudini, anche mentali, che ancora oggi ci impediscono di valutare la caccia quale razionale utilizzazione di una risorsa rinnovabile, come si fa nel Centro-Nord dell’Europa».
Non ce la facevano a campare, allora chiedevano soldi al padrone e per restituirli diventavano bracconieri Un affresco vivace e puntuale della società contadina toscana (ma anche dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria) tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale. Un mondo oggi scomparso, dove i rapporti tra contadino e proprietario erano regolati dalla mezzadria e dove fame e miseria erano le uniche regole di vita per chi coltivava la terra. L’affresco è quello che offre il libro “La vita e le cacce dei contadini fra Ottocento e Novecento - Quando si cacciava per vivere”, dei docenti universitari fiorentini Paolo Casanova e Francesco Sorbetti Guerri (Polistampa, pagg. 195, euro 16). Ne parliamo con Paolo Casanova. Professore, cominciamo dal titolo: chi cacciava per vivere? «Soprattutto erano i mezzadri, coltivatori diretti non proprietari che avevano avuto il fondo in concessione, tramite contratto di mezzadria, da un concedente. Queste forme di agricoltura potevano avere un qualche valore nelle zone fertili di pianura, nelle zone costiere e basso collinari, ma nelle zone montane questa agricoltura era solo di sopravvivenza e spesso non si riusciva neanche a sopravvivere con il raccolto. Di qui la necessità, da una parte, di cercare soldi per campare (quindi indebitamento con il proprietario) e dall’altra di cercare entrate che affiancassero quelle del podere. Siccome per contratto mezzadrile queste persone non potevano lavorare fuori dal podere senza il consenso del concedente, non rimaneva che la caccia per comprare quello che il podere non poteva fornire, come un paio di pantaloni, una giacca, l’aringa, il sale o lo zucchero». C’era differenza tra la miseria dei mezzadri toscani e quella dei contadini bergamaschi dell’“Albero degli zoccoli” di Olmi o quella dei contadini meridionali di Carlo Levi o Ignazio Silone? «La differenza esisteva nella gestione del territorio, ma non nel bilancio familiare. Il fattore comune era dato da scarse conoscenze tecniche, scarsi mezzi, bassi raccolti e insufficienza dei raccolti a fornire la base alimentare per la famiglia colonica per tutto l’anno, con la necessità allora di ricorrere alla caccia, spesso di frodo perché il costo delle licenze, con la legge del ’23, fu aumentato notevolissimamente. Mussolini cercò di troncare il bracconaggio, perché era arrivato al potere anche grazie all’aiuto degli agrari, di conseguenza la legge del ’23 penalizzò chi non aveva soldi, in particolar modo i contadini. Da quell’anno quasi tutti diventarono cacciatori di frodo, perché la legge aveva proibito determinati mezzi prima leciti e perché le tasse per licenza di caccia e porto d’armi non potevano assolutamente rientrare nel bilancio della famiglia contadina diretto-coltivatrice». Si lavorava tanto e si raccoglieva poco. Di qui la necessità di usare il più razionalmente possibile i pochi alimenti a disposizione. «Per forza. Si cucinava con quel pochissimo che c’era, cercando di inventare qualche cosa che più che altro riempisse lo stomaco, perché la cucina colonica era molto voluminosa e basata sulla fibra grezza delle verdure, ma come calorie e come proteine era molto povera. Erano popolazioni perennemente soggette ad una dieta ipocalorica e ipoproteica, tant’è vero che, se andiamo a vedere le misure biometriche alla visita di leva, le popolazioni rurali erano affette da rachitismo. Non per nulla dopo il miracolo economico la statura in Italia è aumentata». Nel libro si dedica molto spazio a descrivere la cucinal, sia come ambiente che come cibi. Colpisce l’ingegno con cui le donne utilizzavano quel poco che c’era. «È chiaro che non c’erano limiti di tempo per cucinare, perché la massaia in genere stava in casa, quindi poteva bollire tutto quello che voleva per il tempo che voleva, però era limitata dalla scelta, cioè dalla cucina colonica, che si basava soprattutto su verdure e in secondo luogo su carboidrati provenienti da quel poco grano del podere, su castagne e patate». Veniamo alle veglie serali. Erano gli unici momenti di socialità? «Sì, perché in genere c’era una conflittualità permanente tra le famiglie coloniche confinanti: i piccioni dell’uno erano andati a beccare nel campo dell’altro, le pecore avevano sconfinato, e così via. Non era affatto un mondo idilliaco». Quando però arrivava il giorno di festa... «Eh, sì, ogni tanto capitava il pranzone. Quando si vedeva la massaia che tirava il collo a qualche pollo, voleva dire che stava arrivando una festa e certamente la cucina diventava molto più ricca, anche per la presenza di paste farcite come tortellini, tortelli, ravioli e altro ancora». Il padrone che atteggiamento aveva verso queste cacce nascoste? «Se era un cacciatore, nasceva una sorta di complicità, purché il colono non diventasse un concorrente. Se non lo era, lasciava perdere, salvo la presenza della normativa prevista dalla legge del 1923 a cui mi riferisco costantemente, perché i guai causati dal fascismo, che noi paghiamo ancora oggi per quanto riguarda la gestione della fauna selvatica, vengono da quella legge che i governanti del dopoguerra non hanno modificato in modo radicale. Mussolini ha sempre appoggiato la caccia di massa, indipendentemente dalla possibilità delle popolazioni selvatiche di sostenere il prelievo venatorio. Ecco allora l’articolo 842 del Codice Civile Rocco che consente ai cacciatori di entrare nei terreni senza chiedere il permesso al proprietario. Una serie di abitudini, anche mentali, che ancora oggi ci impediscono di valutare la caccia quale razionale utilizzazione di una risorsa rinnovabile, come si fa nel Centro-Nord dell’Europa».
Data recensione: 19/06/2007
Testata Giornalistica: Il Tirreno
Autore: Pino Donateo