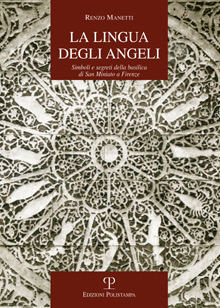Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Quando nell’antico Egitto il dio Theuth si recò dal re Thamos per presentargli le arti che aveva inventato, i numeri, l’abbaco, la geometria, l’astronomia, il gioco delle pietruzze, il gioco dei dadi e le lettere, il sovrano
Quando nell’antico Egitto il dio Theuth si recò dal re Thamos per presentargli le arti che aveva inventato, i numeri, l’abbaco, la geometria, l’astronomia, il gioco delle pietruzze, il gioco dei dadi e le lettere, il sovrano iniziò a fargli le pulci, esaminando le sue invenzioni una per una e accompagnando le lodi per il buono con il biasimo per il poco buono.Dopo che ebbe commentato e giudicato tutte le arti, Thamus si rivolse all’esame delle lettere che Theuth esaltava come medicina della memoria e della sapienza. Il giudizio del re non fu affatto tenero con il dio: «O artificiosissimo Theuth, un conto è esser valenti a partorire le arti, un altro a giudicare del danno e del giovamento che arrecano poi a quelli che le useranno. E ora tu, padre delle lettere, per amore hai affermato che esse compiono il contrario di quello che in realtà fanno. Cioè cagionano lo smemoramento nelle anime di coloro che le hanno apprese, in quanto costoro, fidandosi della scrittura, si rammentano delle cose in virtù di strani segni esterni e non per la capacità di richiamarle da sole alla mente. Dunque non hai trovato la medicina per accrescere la memoria, semmai per rievocare le cose alla memoria. E quanto alla sapienza, tu procuri ai discepoli soltanto la sua apparenza, non la verità. Coloro che leggono molte cose, senza prima aver ricevuto un adeguato insegnamento, si crederanno infatti di esser conoscitori di queste, e invece rimarranno ignoranti e per niente saggi». Con questo mito, che Socrate racconta al giovane Fedro nell’omonimo dialogo, Platone illustra tutta la sua diffidenza nei confronti della scrittura, intesa come strumento di trasmissione del sapere. A suo giudizio soltanto l’oralità può rappresentare il coretto medium della vera scienza (episteme), perché per sua natura – parafrasando il filosofo – non scrive sui rotoli di carta ma direttamente nelle anime degli uomini. Con la sua critica alla scrittura Platone dimostra di aver già perfettamente intuito le pericolose e ampie implicazioni che si celano dietro il suo impiego indiscriminato e scorretto nell’educazione. In particolare è evidente nelle sue parole il timore che la perdita di un adeguato controllo sul sapere e la diffusione di cattive pratiche d’apprendimento producano una conoscenza illusoria, terreno fertile per la mala pianta della presunzione che conduce gli uomini all’errore, adombrando la luce della verità e del giusto. In questo senso la scrittura non è che il primo passo, il primo scollamento del rapporto esclusivo fra docente e discente destinato a diluirsi sempre più, fino ad una totale deriva con Gutenberg prima, e con le tecnologie dell’informazione poi. Per lasciare il Fedro, possiamo dunque sintetizzare il pensiero del filosofo su questo tema introducendo una dicotomia che estremizza in maniera netta il rapporto fra sapere e conoscere, dove il secondo termine viene ad indicare una mera capacità tecnico-operativa (la tecnica di cui parla Emanuele Severino), caratterizzata dall’assenza di una cornice di valori, passioni e sentimenti che lo alimentano e l’orientano verso un’idea di bene. A guardarci intorno non faremmo fatica a riconoscere gli effetti della diffusione del conoscere, come lo abbiamo appena definito, e della pratica di coltivar le menti invece che le anime di cui parlava Platone. Del resto, se la quasi totalità dei testi circola senza – come lo definiva il filosofo – l’aiuto del padre, cioè l’intervento dell’autore che lo spiega o lo racconta, è scontato che si incorra in una sequela interminabile di fraintendimenti e cattive interpretazioni. La questione tocca in maniera cruciale anche le religioni, soprattutto quelle del Libro, dove l’assenza di un’interpretazione del Padre tormenta da millenni teologi e credenti, producendo sconfinate biblioteche di esegeti e battute fulminanti. Come quella dell’ebreo che ottiene dal suo Dio il privilegio di visitare in vita l’inferno e il paradiso. Quando questi lo conduce in paradiso e lui ritrova la stessa palude infestata dalle zanzare nella quale ci sono gli stessi fedeli piegati in lettura sulla Torah che aveva visto all’inferno, chiede atterrito cosa differenzi i due regni. E il suo Dio, con un sorriso beffardo, gli risponde: «Adesso, finalmente, comprendono cosa leggono». La corretta acquisizione e comprensione del sapere è dunque un problema ostico oltre che antico, che non risparmia neppure le sacre scritture e chi avrebbe più mezzi di noi nel farsi intendere. Tuttavia laddove il tempo e lo spazio si sono frapposti fra sapienti e ignoranti, la scrittura è stata storicamente il miglior succedaneo dell’oralità, permettendo al sapere di attraversare le montagne, i mari e i secoli. Se è vero poi che ha reso gli uomini più smemorati, come rilevano anche molti studi sulle culture basate sulla tradizione orale, di contro ha permesso uno sviluppo nell’elaborazione del pensiero inimmaginabile per l’oralità. Senza contare poi che la scriptio continua degli antichi greci e romani, con la quale i testi prendevan la forma di lunghe catene di lettere senza alcuna interruzione per lo stilo dello scrivano e l’occhio del lettore, ha subito un notevole processo evolutivo nel tempo che ha enormemente potenziato le sue possibilità espressive, riducendo di conseguenza anche la discrepanza fra sapere e conoscere. Ciononostante il problema della trasmissione corretta del sapere attraverso un testo scritto (ma il discorso si può ampliare anche ad altre modalità di comunicazione, compresa la stessa oralità), costituisce una questione complessa, di difficile risoluzione. Una luce che offre una visione diversa della questione e in parte la scioglie l’ho trovata in un libro che ho presentato in questa rubrica qualche settimana fa, La lingua degli angeli di Renzo Manetti. L’opera è un’interessantissima analisi della chiesa di San Miniato al Monte di Firenze compiuta sui binari dell’architettura sacra, che collega il suo progetto, le sue geometrie interne ed esterne,ad una complessa dimensione simbolica di matrice medievale. A parte il fascino per i contenuti, il libro colpisce anche per la sua architettura narrativa, per la sua brillante soluzione del rapporto fra testo e lettura, che non risolve definitivamente il cruccio di Platone ma indubbiamente elabora un’esposizione molto coinvolgente, nella quale l’autore si preoccupa di sedurre il lettore oltre a nutrire il suo intelletto. Poche parole dopo l’incipit campeggia infatti l’epigrafe latina del pavimento della chiesa fiorentina che l’autore si affretta a definire di difficile traduzione, tranne un frammento carico di forza enigmatica: “queste cose preservano dal tempo e dalla morte”. È l’innesco narrativo che accende la curiosità del lettore, la sua brama di sapere. Creato il desiderio, la tensione verso la verità che ne scaturisce è sfruttata dall’autore per condurre il lettore lungo un percorso articolato in dieci capitoli. Ciascun di questi può essere considerato come un gradino iniziatico nel quale l’adepto viene messo a parte di una porzione di sapere, necessaria sia a comprendere il gradino successivo che ad accrescere la sua voglia di conoscere l’intero disegno. Con questo espediente l’autore governa così la relazione di apprendimento e modula la trasmissione del sapere, che può procedere verticalmente, secondo un ordine crescente della complessità, oppure orizzontalmente, fornendo elementi aggiuntivi per ampliare la conoscenza finale. Nel caso de La lingua degli angeli la chiave dell’enigma, che conclude il percorso narrativo del lettore, è rappresentata dalle sei righe della traduzione dell’epigrafe iniziale. Leggerla è come accendere un faro… Il suo senso si riempie del sapere cresciuto nel percorso svolto e a sua volta lo illumina conferendogli la compiutezza di un cerchio che si chiude. Questo cerchio, macchina e strategia testuale al tempo stesso, serve per far crescere il lettore, per trasformarlo in vista dell’ultima acquisizione, per elevarlo fino a raggiungere la chiave di volta, che non innalza oltre la struttura ma trasforma due braccia di cunei in un arco stabile. Se il lettore invece fosse saltato subito all’ultima pagina per leggere la corretta traduzione dell’epigrafe avrebbe appreso soltanto il suo significato letterale, assolutamente inservibile a comprendere il senso profondo di quell’iscrizione. Una chiave di volta senza l’arco per il quale è stata tagliata è infatti soltanto una pietra. In conclusione, cos’altro è quest’arco se non una forma solida di sapere alimentata dal desiderio di conoscere, cementata dalla fatica dell’apprendimento e consolidata dalla sua bellezza finale? In analogia con l’armonia universale dei pitagorici, il sapiente deve dunque costruire il suo arco ad arte, ovvero rispettando le regole semiotiche della narratività. Soltanto così può sperare di assoldare la bellezza e il pathos necessari a trasformare il suo sapere in verità. Soltanto così si può sperare di costruire, arco dopo arco e arco su arco, scuole e città che non crollano. Il timore di Platone era appunto che la scrittura non riuscisse a far questo, lasciando l’allievo libero di pascolare da una pagina all’altra e di brucare unicamente quello che gli piaceva rimanendo sostanzialmente ignaro delle cose importanti.
Data recensione: 21/04/2009
Testata Giornalistica: Metropoli
Autore: Jacopo Nesti