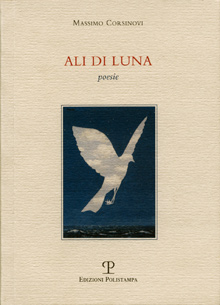Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Ho incontrato Massimo Corsinovi attraverso Ali di luna. Questo libro è stata l’occasione per incontrare – ecco, questo lo voglio dire subito – un poeta
Ho incontrato Massimo Corsinovi attraverso Ali di luna.
Questo libro è stata l’occasione per incontrare – ecco, questo lo voglio dire subito – un poeta.
Un vero poeta.
Spero che tutti siate d’accordo con me nel riconoscere quanto sia raro questo: incontrare un poeta.
Per la verità io Corsinovi l’ho incontrato stamattina, di persona. Ci eravamo già sfiorati qualche anno fa, in occasione di un convegno su Luzi, un poeta che amiamo entrambi e che entrambi consideriamo un maestro. Ma solo sfiorati, non avrei saputo riconoscerlo.
Stamattina invece, per caso, io stavo andando in ufficio – perché anche i filosofi vanno in ufficio – e qui in via Cavour Massimo mi ha fermato. E, come accade, ho risposto al suo saluto un po’ impacciato, entrando subito in argomento, ma malamente, cercando di dire qualcosa delle impressioni che mi hanno fatto le sue poesie.
Proprio da qui vorrei partire – da quello che stamattina, malamente e con un certo imbarazzo, io ho detto a Massimo – per costruire un piccolo discorso interpretativo.
Se ricordo bene gli ho detto: sono belle le tue poesie. Anzi, ho usato un aggettivo forse un po’ scontato: sono incantevoli.
E ho creduto di dover aggiungere: cosa rara, un piccolo miracolo, questo tuo riuscire a ritrovare l’incanto in un mondo come il nostro che è, come tutti noi sappiamo anche troppo bene, disincantato.
Ecco, la poesia di Massimo Corsinovi è anzitutto questo: una capacità, una forza, un’energia, una vera e propria potenza del linguaggio, che riesce a sprigionare dal linguaggio stesso un incanto, là dove sembrerebbe impossibile ritrovarlo, l’incanto, nel nostro mondo disincantato.
E, proseguendo poi per la mia strada, sapendo che stasera sarei venuto qui a presentare le sue poesie, mi sono chiesto: ma perché questo? Che cos’è che permette a Massimo Corsinovi questo piccolo miracolo?
Io credo che la risposta l’abbia già data Mario Luzi quando ha definito Massimo Corsinovi il “poeta del silenzio”.
È un ammirevole lavoro sul linguaggio quello che permette a Corsinovi di trovare l’incanto nel disincantamento. Un lavoro sul linguaggio che riporta il linguaggio alla propria fonte. All’essenziale, al silenzio. Perché questo è il silenzio: la fonte di ogni dire, la fonte stessa del linguaggio.
Un vero e proprio contromovimento: dall’inessenziale all’essenziale, dall’esteriorità all’interiorità, dal rumore che ci circonda – quel rumore che come fatto linguistico è chiacchiera – alla parola che è capace di dire, appunto, qualcosa di essenziale.
Questo è il lavoro fatto dal poeta. Sì, il lavoro: anche dei poeti si deve dire che lavorano.
Appunto, il lavoro fatto da Massimo sul linguaggio.
Però, attenzione: questo contromovimento, che porta dall’esteriorità all’interiorità, dal rumore al silenzio, non deve assolutamente essere confuso con quanto è stato fatto in molte altre esperienze poetiche del Novecento, anche con grandi risultati, ma in un senso opposto al suo, in un senso che definirei – per intenderci – nichilistico.
Penso, per esempio, alla famosa Lettera di Lord Chandos di Hoffmannsthal.
Dice in sostanza Hoffmannsthal: le parole hanno perso la loro capacità di dire le cose. Le cose si sono fatte impenetrabili, indicibili.
Non perché siano tornate a quel loro punto di origine che è il silenzio, ma perché nel silenzio hanno trovato la loro tomba. Il mondo si è fatto vano perché non c’è più nessuno che riesca a esprimerlo.
Non c’è più nessuno che abbia la forza, l’energia di un linguaggio veramente significativo.
Rilke negli stessi anni, siamo all’inizio del secolo, si chiedeva: chi ha ancora la capacità di nominare le cose di uso quotidiano, riconoscendo in esse tutta la nostra ricchezza?
Chi ha ancora la capacità di dire una brocca piena d’acqua , ritrovando in questo suo semplice dire tutta l’ infinita carica espressiva che c’è nelle semplici parole: brocca – piena – d’acqua? Chi sa ancora dire fonte , bastone, e così via?
Noi non sappiamo più nominare le cose. E perciò le cose si sono fatte opache. Ma non solo opache, impenetrabili.
Questa impenetrabilità ha fatto sì che il linguaggio sia imploso, sia per così dire caduto dentro il nulla linguistico che è appunto l’impossibilità di dire alcunché.
E da Hoffmannsthal a Rilke – che nonostante tutto ha tentato ancora di dire l’essenziale – su su fino a Beckett, abbiamo a che fare con quella che non saprei definire altrimenti che l’implosione nichilistica del linguaggio.
Massimo Corsinovi compie un’operazione analoga. Apparentemente analoga. Ma, in realtà, di segno contrario. Perché lui riporta il linguaggio alla sua origine, ma in essa vede non tanto il buio, non tanto un silenzio muto, un silenzio silenzioso, inespressivo, inerte.
Nel silenzio egli vede invece l’origine. Vede qualcosa di musicale: il silenzio musicale è quello a cui ci richiama la poesia di Massimo Corsinovi.
È il silenzio dentro il quale è possibile ritrovare la capacità essenziale della nominazione.
Da questo punto di vista la poesia di Massimo Corsinovi si inserisce in una precisa linea poetica. I suoi poeti sono quelli e non quegli altri.
Primo fra tutti Rebora. Certo, e chi se non lui, capace per l’appunto di ritrovare nella parola, la parola che usiamo tutti i giorni, quelle profonde risonanze che non possiamo definire altrimenti che religiose? Ma poi anche Ungaretti. A lui forse ancora più vicino sembra il suo dettato , la sua poetica. Ungaretti, non Montale. Ungaretti, con la sua ricerca, anche lui, dell’essenziale. Non Montale, con quell’esito sarcastico, beffardo di Satura e delle poesie successive. Dove, appunto, compito del linguaggio sembra essere soltanto quello di implodere nel linguaggio, ammutolendolo.
Corsinovi sta invece con Ungaretti, con Rebora. Ma, prima ancora, con i mistici. Non si può non pensare ad Angelo Silesio, il grande mistico secentesco, l’ultimo della tradizione renana, leggendo queste poesie. Lungo questa linea certamente minoritaria Corsinovi si dispone all’ascolto dell’essenziale, e mentre si rivolge al mondo delle cose prossime (sia che si tratti di cose sia che si tratti di persone), di fatto innesca un movimento per cui il lettore viene trascinato in alto, su su , attraverso un vero e proprio itinerarium mentis in Deum. Viene trascinato dal mondo delle cose prossime al mondo delle cose ultime. Tanto che questa poesia ha davvero una carica mistica, religiosa e teologica impressionante. Tanto più impressionante, quanto più si limita a nominare le cose prossime.
Il poeta ci parla di un raggio della luna, così come ci parla anche delle nuvole che si appoggiano sugli ulivi, di quei nidi che si nascondono nei rami dei cipressi e che altro non sono che i nostri stessi sogni. Ci parla appunto di tutto ciò che noi ben conosciamo, perché è cosa nostra, ma facendoci vedere in tutto ciò qualcos’altro. Qualcosa di infinitamente più ampio e più comprensivo.
Questo lo rivela anche il fatto che ogni sezione di questa raccolta poetica è dedicata a una persona: può essere il padre e la sua ultima carezza. Può essere la madre, donna lieta nel suo soffrire. O la nonna, che prende congedo dalla vita con un semplice gesto del capo.
Ma può anche essere la vita nascente, la vita del proprio figlio di cui si intravede il volto come in trasparenza, prima ancora di essere nato, nel sangue. Nel sangue stesso di colei che sta per partorirlo.
Ecco come le cose prossime lasciano in trasparenza vedere qualche cosa che prossimo non è. Che, anzi, è ultimo. Ma di cui percepiamo, qui e ora, il riflesso. Quel qui e ora che è qui e ora, come dice un altro dei suoi distici, ma è nello stesso tempo lontano.
Ecco, quella di Massimo Corsinovi è una autentica poesia mistica. È una poesia mistica, è una poesia religiosa e, lasciatemelo dire, è una poesia teologica.
È difficile cogliere questo aspetto a una prima lettura, però si impone subito.
Difficile da cogliere perché – potrebbe chiedersi il lettore – dov’è la religiosità, dov’è il contenuto teologico in tre versi come questi: “Sul lungomare deserto – al vento lente oscillano – vecchie sedie a dondolo”?
Oppure in questi altri: “La neve era farina – lo specchio un grande lago – tra statue e borraccina”?
Ma poi subito dopo, ecco che i tre versi qui si disarticolano, per così dire. E non a caso vengono stampati due in una pagina e uno in un’altra, come se il respiro richiedesse un più ampio movimento spirituale: “Con mio padre e mia madre – vivevo il mio presepe”. Poi c’è un lungo spazio bianco. E al distico segue nell’altra pagina un unico verso: “Torna, a volte, l’incanto.”
Un presepio: vale a dire niente, o un quasi niente. Ed è tutto.
Anche qui, quel farsi essenziale del dettato, così essenziale che non può neppure essere detto – la pagina bianca – apre a un incanto che ci viene incontro senza soluzione di continuità e tuttavia nella discontinuità di una grande trascendenza, di un grande distacco, di una grande lontananza.
Il presepe è qui, lo vediamo, sotto gli occhi dei nostri bambini, e nostri. È qui, ma è anche in noi, perché è incantevole, perché ci restituisce a un incanto , perduto il quale è perduto tutto.
“sinite parvulo…”. Perché chi non torna bambino non va in Paradiso. Solo chi di noi saprà ritrovare quello sguardo infantile, ma così profondo e così capace di incanto, solo chi di noi tornerà bambino… Solo chi sarà capace di questo miracolo, di questa cosa impossibile, solo a costui si apriranno le porte del regno dei cieli.
In questi versi c’è lo sguardo. C’è la conversione dello sguardo. C’è la restituzione, la riconsegna a un modo di guardare la realtà capace di cogliere nella realtà più minuta e insignificante, l’essenziale.
E questa è teologia. Questa è poesia teologica.
Quale teologia? Ecco, vorrei fare un’ipotesi. E comincerei riferendomi alle due grandi scuole teologiche che hanno dominato il Novecento. Anzitutto la teologia dell’incarnazione. Che dice: solo nell’invisibile che si fa visibile, solo nel soprannaturale e nel disincarnato che si fa carne, è per noi possibile fare esperienza del divino.
C’è poi la Theologia Crucis, la teologia del sacrificio, e della redenzione. Quella teologia che ha permesso al padre Fausto Sbaffoni nella sua bella prefazione di parlare, sulla scia dell’autore, di una poetica della ablatio. Di una poetica della cancellazione di tutto ciò che è inessenziale, alla ricerca di quell’essenziale che è nella parola, non al di là della parola – poetica della ablatio che si accompagna, aggiungerei io, a una poetica della oblatio. Cioè del sacrificio. E della purificazione. Ecco perché questa operazione ablativa è sempre anche una operazione oblativa. Perché cancellare significa anche sacrificarsi. Luzi non a caso ha parlato, a proposito della poesia di Massimo, non soltanto di poesia del silenzio, ma anche di poesia dell’Agnus, dell’Agnello sacrificale.
Ma al di là della teologia dell’incarnazione e della crocifissione c’è la teologia dell’annunciazione.
Che cos’è infatti l’annunciazione se non quel momento di sospensione in cui la quotidianità – Maria nella sua casa visitata dall’Angelo – viene sorpresa appunto da un annuncio smisurato e incredibile?
La poesia di Massimo Corsinovi sta nel segno della teologia della annunciazione in quanto tiene insieme questi due momenti: il momento dell’ascolto e il momento della parola. Ed è il paradosso più grande. Per ascoltare bisogna far silenzio. Condurre tutte le parole nel silenzio. Ma che cosa c’è, nel cuore del silenzio, se non la parola? Compito del poeta altro non è che l’ascolto di una parola che il silenzio non imprigiona, ma sprigiona.
Questo libro è stata l’occasione per incontrare – ecco, questo lo voglio dire subito – un poeta.
Un vero poeta.
Spero che tutti siate d’accordo con me nel riconoscere quanto sia raro questo: incontrare un poeta.
Per la verità io Corsinovi l’ho incontrato stamattina, di persona. Ci eravamo già sfiorati qualche anno fa, in occasione di un convegno su Luzi, un poeta che amiamo entrambi e che entrambi consideriamo un maestro. Ma solo sfiorati, non avrei saputo riconoscerlo.
Stamattina invece, per caso, io stavo andando in ufficio – perché anche i filosofi vanno in ufficio – e qui in via Cavour Massimo mi ha fermato. E, come accade, ho risposto al suo saluto un po’ impacciato, entrando subito in argomento, ma malamente, cercando di dire qualcosa delle impressioni che mi hanno fatto le sue poesie.
Proprio da qui vorrei partire – da quello che stamattina, malamente e con un certo imbarazzo, io ho detto a Massimo – per costruire un piccolo discorso interpretativo.
Se ricordo bene gli ho detto: sono belle le tue poesie. Anzi, ho usato un aggettivo forse un po’ scontato: sono incantevoli.
E ho creduto di dover aggiungere: cosa rara, un piccolo miracolo, questo tuo riuscire a ritrovare l’incanto in un mondo come il nostro che è, come tutti noi sappiamo anche troppo bene, disincantato.
Ecco, la poesia di Massimo Corsinovi è anzitutto questo: una capacità, una forza, un’energia, una vera e propria potenza del linguaggio, che riesce a sprigionare dal linguaggio stesso un incanto, là dove sembrerebbe impossibile ritrovarlo, l’incanto, nel nostro mondo disincantato.
E, proseguendo poi per la mia strada, sapendo che stasera sarei venuto qui a presentare le sue poesie, mi sono chiesto: ma perché questo? Che cos’è che permette a Massimo Corsinovi questo piccolo miracolo?
Io credo che la risposta l’abbia già data Mario Luzi quando ha definito Massimo Corsinovi il “poeta del silenzio”.
È un ammirevole lavoro sul linguaggio quello che permette a Corsinovi di trovare l’incanto nel disincantamento. Un lavoro sul linguaggio che riporta il linguaggio alla propria fonte. All’essenziale, al silenzio. Perché questo è il silenzio: la fonte di ogni dire, la fonte stessa del linguaggio.
Un vero e proprio contromovimento: dall’inessenziale all’essenziale, dall’esteriorità all’interiorità, dal rumore che ci circonda – quel rumore che come fatto linguistico è chiacchiera – alla parola che è capace di dire, appunto, qualcosa di essenziale.
Questo è il lavoro fatto dal poeta. Sì, il lavoro: anche dei poeti si deve dire che lavorano.
Appunto, il lavoro fatto da Massimo sul linguaggio.
Però, attenzione: questo contromovimento, che porta dall’esteriorità all’interiorità, dal rumore al silenzio, non deve assolutamente essere confuso con quanto è stato fatto in molte altre esperienze poetiche del Novecento, anche con grandi risultati, ma in un senso opposto al suo, in un senso che definirei – per intenderci – nichilistico.
Penso, per esempio, alla famosa Lettera di Lord Chandos di Hoffmannsthal.
Dice in sostanza Hoffmannsthal: le parole hanno perso la loro capacità di dire le cose. Le cose si sono fatte impenetrabili, indicibili.
Non perché siano tornate a quel loro punto di origine che è il silenzio, ma perché nel silenzio hanno trovato la loro tomba. Il mondo si è fatto vano perché non c’è più nessuno che riesca a esprimerlo.
Non c’è più nessuno che abbia la forza, l’energia di un linguaggio veramente significativo.
Rilke negli stessi anni, siamo all’inizio del secolo, si chiedeva: chi ha ancora la capacità di nominare le cose di uso quotidiano, riconoscendo in esse tutta la nostra ricchezza?
Chi ha ancora la capacità di dire una brocca piena d’acqua , ritrovando in questo suo semplice dire tutta l’ infinita carica espressiva che c’è nelle semplici parole: brocca – piena – d’acqua? Chi sa ancora dire fonte , bastone, e così via?
Noi non sappiamo più nominare le cose. E perciò le cose si sono fatte opache. Ma non solo opache, impenetrabili.
Questa impenetrabilità ha fatto sì che il linguaggio sia imploso, sia per così dire caduto dentro il nulla linguistico che è appunto l’impossibilità di dire alcunché.
E da Hoffmannsthal a Rilke – che nonostante tutto ha tentato ancora di dire l’essenziale – su su fino a Beckett, abbiamo a che fare con quella che non saprei definire altrimenti che l’implosione nichilistica del linguaggio.
Massimo Corsinovi compie un’operazione analoga. Apparentemente analoga. Ma, in realtà, di segno contrario. Perché lui riporta il linguaggio alla sua origine, ma in essa vede non tanto il buio, non tanto un silenzio muto, un silenzio silenzioso, inespressivo, inerte.
Nel silenzio egli vede invece l’origine. Vede qualcosa di musicale: il silenzio musicale è quello a cui ci richiama la poesia di Massimo Corsinovi.
È il silenzio dentro il quale è possibile ritrovare la capacità essenziale della nominazione.
Da questo punto di vista la poesia di Massimo Corsinovi si inserisce in una precisa linea poetica. I suoi poeti sono quelli e non quegli altri.
Primo fra tutti Rebora. Certo, e chi se non lui, capace per l’appunto di ritrovare nella parola, la parola che usiamo tutti i giorni, quelle profonde risonanze che non possiamo definire altrimenti che religiose? Ma poi anche Ungaretti. A lui forse ancora più vicino sembra il suo dettato , la sua poetica. Ungaretti, non Montale. Ungaretti, con la sua ricerca, anche lui, dell’essenziale. Non Montale, con quell’esito sarcastico, beffardo di Satura e delle poesie successive. Dove, appunto, compito del linguaggio sembra essere soltanto quello di implodere nel linguaggio, ammutolendolo.
Corsinovi sta invece con Ungaretti, con Rebora. Ma, prima ancora, con i mistici. Non si può non pensare ad Angelo Silesio, il grande mistico secentesco, l’ultimo della tradizione renana, leggendo queste poesie. Lungo questa linea certamente minoritaria Corsinovi si dispone all’ascolto dell’essenziale, e mentre si rivolge al mondo delle cose prossime (sia che si tratti di cose sia che si tratti di persone), di fatto innesca un movimento per cui il lettore viene trascinato in alto, su su , attraverso un vero e proprio itinerarium mentis in Deum. Viene trascinato dal mondo delle cose prossime al mondo delle cose ultime. Tanto che questa poesia ha davvero una carica mistica, religiosa e teologica impressionante. Tanto più impressionante, quanto più si limita a nominare le cose prossime.
Il poeta ci parla di un raggio della luna, così come ci parla anche delle nuvole che si appoggiano sugli ulivi, di quei nidi che si nascondono nei rami dei cipressi e che altro non sono che i nostri stessi sogni. Ci parla appunto di tutto ciò che noi ben conosciamo, perché è cosa nostra, ma facendoci vedere in tutto ciò qualcos’altro. Qualcosa di infinitamente più ampio e più comprensivo.
Questo lo rivela anche il fatto che ogni sezione di questa raccolta poetica è dedicata a una persona: può essere il padre e la sua ultima carezza. Può essere la madre, donna lieta nel suo soffrire. O la nonna, che prende congedo dalla vita con un semplice gesto del capo.
Ma può anche essere la vita nascente, la vita del proprio figlio di cui si intravede il volto come in trasparenza, prima ancora di essere nato, nel sangue. Nel sangue stesso di colei che sta per partorirlo.
Ecco come le cose prossime lasciano in trasparenza vedere qualche cosa che prossimo non è. Che, anzi, è ultimo. Ma di cui percepiamo, qui e ora, il riflesso. Quel qui e ora che è qui e ora, come dice un altro dei suoi distici, ma è nello stesso tempo lontano.
Ecco, quella di Massimo Corsinovi è una autentica poesia mistica. È una poesia mistica, è una poesia religiosa e, lasciatemelo dire, è una poesia teologica.
È difficile cogliere questo aspetto a una prima lettura, però si impone subito.
Difficile da cogliere perché – potrebbe chiedersi il lettore – dov’è la religiosità, dov’è il contenuto teologico in tre versi come questi: “Sul lungomare deserto – al vento lente oscillano – vecchie sedie a dondolo”?
Oppure in questi altri: “La neve era farina – lo specchio un grande lago – tra statue e borraccina”?
Ma poi subito dopo, ecco che i tre versi qui si disarticolano, per così dire. E non a caso vengono stampati due in una pagina e uno in un’altra, come se il respiro richiedesse un più ampio movimento spirituale: “Con mio padre e mia madre – vivevo il mio presepe”. Poi c’è un lungo spazio bianco. E al distico segue nell’altra pagina un unico verso: “Torna, a volte, l’incanto.”
Un presepio: vale a dire niente, o un quasi niente. Ed è tutto.
Anche qui, quel farsi essenziale del dettato, così essenziale che non può neppure essere detto – la pagina bianca – apre a un incanto che ci viene incontro senza soluzione di continuità e tuttavia nella discontinuità di una grande trascendenza, di un grande distacco, di una grande lontananza.
Il presepe è qui, lo vediamo, sotto gli occhi dei nostri bambini, e nostri. È qui, ma è anche in noi, perché è incantevole, perché ci restituisce a un incanto , perduto il quale è perduto tutto.
“sinite parvulo…”. Perché chi non torna bambino non va in Paradiso. Solo chi di noi saprà ritrovare quello sguardo infantile, ma così profondo e così capace di incanto, solo chi di noi tornerà bambino… Solo chi sarà capace di questo miracolo, di questa cosa impossibile, solo a costui si apriranno le porte del regno dei cieli.
In questi versi c’è lo sguardo. C’è la conversione dello sguardo. C’è la restituzione, la riconsegna a un modo di guardare la realtà capace di cogliere nella realtà più minuta e insignificante, l’essenziale.
E questa è teologia. Questa è poesia teologica.
Quale teologia? Ecco, vorrei fare un’ipotesi. E comincerei riferendomi alle due grandi scuole teologiche che hanno dominato il Novecento. Anzitutto la teologia dell’incarnazione. Che dice: solo nell’invisibile che si fa visibile, solo nel soprannaturale e nel disincarnato che si fa carne, è per noi possibile fare esperienza del divino.
C’è poi la Theologia Crucis, la teologia del sacrificio, e della redenzione. Quella teologia che ha permesso al padre Fausto Sbaffoni nella sua bella prefazione di parlare, sulla scia dell’autore, di una poetica della ablatio. Di una poetica della cancellazione di tutto ciò che è inessenziale, alla ricerca di quell’essenziale che è nella parola, non al di là della parola – poetica della ablatio che si accompagna, aggiungerei io, a una poetica della oblatio. Cioè del sacrificio. E della purificazione. Ecco perché questa operazione ablativa è sempre anche una operazione oblativa. Perché cancellare significa anche sacrificarsi. Luzi non a caso ha parlato, a proposito della poesia di Massimo, non soltanto di poesia del silenzio, ma anche di poesia dell’Agnus, dell’Agnello sacrificale.
Ma al di là della teologia dell’incarnazione e della crocifissione c’è la teologia dell’annunciazione.
Che cos’è infatti l’annunciazione se non quel momento di sospensione in cui la quotidianità – Maria nella sua casa visitata dall’Angelo – viene sorpresa appunto da un annuncio smisurato e incredibile?
La poesia di Massimo Corsinovi sta nel segno della teologia della annunciazione in quanto tiene insieme questi due momenti: il momento dell’ascolto e il momento della parola. Ed è il paradosso più grande. Per ascoltare bisogna far silenzio. Condurre tutte le parole nel silenzio. Ma che cosa c’è, nel cuore del silenzio, se non la parola? Compito del poeta altro non è che l’ascolto di una parola che il silenzio non imprigiona, ma sprigiona.
Data recensione: 01/10/2008
Testata Giornalistica: Rivista di Ascetica e Mistica
Autore: Sergio Givone