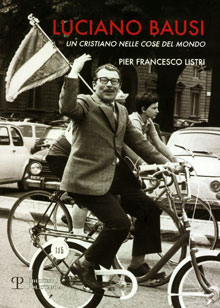Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Quando, lo scorso settembre, Giorgio Luti mi contattò per propormi la presentazione della raccolta In transito al Gabinetto Vieusseux, non conoscevo Anna Maria Guidi, sul momento non
Quando, lo scorso settembre, Giorgio Luti mi contattò per propormi la presentazione della raccolta In transito al Gabinetto Vieusseux, non conoscevo Anna Maria Guidi, sul momento non ricordavo nemmeno di avere avuto occasione di tenere tra le mani uno dei suoi libri di poesia precedenti, per la precisione il secondo, Incontri del 2000 (Polistampa, Presentazione di Carmelo Mezzasalma), gli altri sono Esercizi (Polistampa, 1998, Presentazione di Luti), Tenacia d’ombra (Polistampa, 2002, Presentazione di Giuseppe Panella), Certezze (Ibiskos, 2002, Presentazione di Cristiano Mazzanti). Un bel libro, come dimostrano i molti premi ottenuti, che allora mi aveva colpito in primo luogo per la tanta materia presente, per le tante cose che si percepiva l’Autrice aveva da dire, avrebbe voluto dire, che le si ingorgavano addirittura in gola, fino a dover ricorrere a uno sperimentalismo grafico della parola, oscillando tra misure metriche tradizionali e espedienti di poesia visiva. D’altra parte, come la stessa Guidi dichiarava indicando “personaggi ed interpreti” della raccolta, protagonisti erano allora “Tutti quelli che mente sgombra e sensi pronti, in intima coerenza nella mutevolezza del divenire, consentono di incontrare, fuori e dentro di sé”, e quindi: pensieri, sentimenti, passioni, desideri, felicità, dolore, tenerezza e via via dicendo. Da tale materia nascevano versi come quelli della poesia che apriva il libro: “Gialla / mi apre gli occhi / stamani un’altra primavera / di ranuncoli che fremono / a distesa tentazioni / di festa. // Mi preparo a riceverla / di cristalli e d’argenti / apparecchiando la tavola imbandita / dei pensieri. // È qui con me ora: / la prima sempre / di tutte quelle che non so / se mi restano”. Giustamente Mezzasalma, nell’introduzione, parlava del tono della voce di Anna Maria, “che non è solamente lo stile di una scrittura”, bensì “si fa sentire come una nota umana e come un timbro misterioso allo stesso tempo, che accompagna le vicissitudini del vivere e del pensare a contatto con la vita”. Da allora sono trascorsi cinque anni durante i quali sono, appunto, uscite altre raccolte che permettono di seguire un percorso creativo senza alcun dubbio in crescita, peraltro, come sempre accade, con battute d’arresto, momentanei smarrimenti propri di chi va e si va cercando. Fino ad arrivare al libro che oggi presentiamo, In transito, dedicato con formula felice “A chi mi tiene / senza trattenermi”. Lo definirei un libro che segna, in termini inequivocabili, una svolta nell’iter di Anna Maria; un libro dove quanto di meglio era sin da Esercizi presente – e il meglio era per me quel flusso di vita, che una memoria ovattata di volta in volta restituiva al lettore, una memoria di cui l’Autrice era ed è la prima e unica vestale, la custode di un fuoco e di un focolare domestico insieme – trova conferma e, allo stesso tempo, sono superate le prime incertezze di una ricerca espressiva che è andata definendosi in un personale e inconfondibile metro. Ancora una volta la materia è tanta e non solo quantitativamente: è la materia di una vita, di una vita vissuta come “magnifico esercizio” (ci diceva Anna Maria nel suo libro di esordio), di una vita registrata attimo per attimo dalle battaglie interiori di una giovinezza tormentata, alle asperità di una crescita sempre provvisoria, su su fino ai “raccolti d’armonia” mai ottenuti percorrendo strade facili e in discesa, bensì “vorticando, annaspando, defluendo”. D’altra parte, come lo stesso titolo bene indica, “transitare” equivale ad alludere a uno stato di continua incertezza, dove nulla è mai definitivo e dove, afferma con coraggiosa sincerità l’Autrice, “mi pesa la zavorra / fardello di paura”. E il libro stesso è costruito come un transito attraverso tredici movimenti, segnalati da altrettante poesie in corsivo, il cui primo verso è riportato nell’indice finale: inumate le spoglie; un amico m’ha detto; costosi / non preziosi; in girotondi / farnetici di foglie; colgo / acini rosseggianti; in piedi / tre scalini più in basso; occlude il parafuoco; è pane e di sciplina; pudica vestale; non volli conoscere; molto ho visto; dispaiono le schiere dell’agire; una volta / tanti treni fa. Movimenti che, come giustamente osserva Luti nell’introduzione, di volta in volta si dispongono fra “il dovere di vivere / e l’invenzione di tenere in vita / la necessità della vita”. Alcuni anni fa, in particolare nella seconda metà degli anni Settanta, ci sarebbe stato chi, nell’ambito di un vivace dibattito allora in voga sulla poesia femminile, non avrebbe mancato di interrogarsi, pur rifiutando qualsiasi separazione tra maschile e femminile in letteratura, su dove collocare la ricerca poetica di un’Autrice come la Guidi, che nello sciorinare, proprio nel senso di esporre all’aria e al sole, i propri punti di vista, i miti, le fantasie, i desideri esprime tutte le tappe di una ricerca di identità, di una vera e propria catarsi che, nel suo essere individuo donna, trova a mio avviso l’ingrediente principale. Intendiamoci bene, però, nel senso e nella misura indicati da un’altra grande poetessa fiorentina cui a tratti mi riporta la lettura dei versi di Anna Maria, Margherita Guidacci. Interrogata sull’esistenza o meno di un rapporto, in una donna che scriva poesie, tra l’esser donna, appunto, e lo scrivere poesie, la Guidacci (1976) rispondeva affermativamente, precisando: “Il sesso di una persona, come il suo luogo di nascita, il tempo in cui è vissuta, l’ambiente in cui si è formata, gli incontri (esistenziali o culturali) che ha avuto, l’aspetto fisico, le condizioni economiche, la buona o cattiva salute, fanno parte delle premesse su cui si è sviluppata la sua vita individuale (senza la quale non si sarebbe mai sviluppata la sua poesia): è uno dei dati del problema che le è toccato risolvere”. Non tanto, quindi, la condizione femminile come fattore primariamente influenzante lo scrivere versi, bensì come premessa essenziale per la crescita di una personalità, di una vita individuale appunto da cui la poesia, la vera poesia, potrà germogliare. A precisarne il senso, mi piace qui ricordare quanto Enrico Falqui osservava alla fine degli anni Cinquanta a proposito della poesia femminile nel dopoguerra, quando scriveva che le poetesse più giovani “si aggiravano tra i ricordi come tra le macerie di un diseredato mondo lunare”. E non è forse la contemporaneità in cui Anna Maria è così visceralmente immersa un diseredato universo, che l’Autrice di volta in volta dipinge con le variegate tinte della sua personale tavolozza? Talora si limita a prenderne atto (se necessario, anche con sottile ironia), talaltra sembra subirne la forza distruttrice, “Anche per oggi smonto / dal pubblico castigo: / bugnato di sorrisi sovraesposti, / quotidiano artefatto / adeso – comme il faut – alla facciata. // Paterna mi rimbocca / la notte le lenzuola. // Superstite m’accovo / in isole di pena: // poi senza mappa trovo, / diserto in una crepa dell’intonaco, / il tesoro del pianto” (Il tesoro). Ma non certo la rassegnazione è il sentimento che percepisce chi questi versi si trovi ad attraversare. Sono, piuttosto, l’attrazione e lo stupore per il coraggioso “azzardo” di un volo che uno “sgricciolo in ali” e senza rete – aggiungo io – compie leggero e spregiudicato, con la vertigine di una leggerezza “abbacinante” e nonostante il peso di un “deserto di stanchezze”. Le immagini si rincorrono ancora numerose e senza fiato di questa esploratrice dai piedi alati, che non “si ispira” ma “aspira” – sono sue parole – da quello che chiama “l’incenso sottile della vita”: dai meandri più riposti della mente, a una orchestrazione delle infinite sfumature dell’anima, ai più minuti palpiti di una natura sempre e comunque madre. Una natura dove il sentimento poetico della voce di Anna Maria trova spesso origine e sostegno, andando ben oltre una paesaggistica registrazione di fatti altrimenti fine a se stessa. Anzi si potrebbe dire che tutto qui diventa natura, il paesaggio come il dolore, perché l’essere (per quanto personale e soggettivo) è tutto l’essere e ogni aspetto dell’esistere si concreta nel creato: “D’estate, / qui sul pianoro / scabro della pescaia, / c’è un sentore di mare decomposto / che ha scambiato la spiaggia con le sponde: / e non sa defluire / per ritornare in sé. // Qui ricovero e asciugo il mio sudore / di ronzino sfranto allo stallaggio, / qui baratto gli strappi / del morso che costringe, claudicante, / la gara del vivere col convivere, / col cosmico conflato dell’esistere” (Lo sposlizio); “Imbrina il giorno. // Offerta in sacrificio alla vendemmia, / arrosa e infuma / rampicando crinali / l’assorta mestizia delle vigne. // Assaporarla e assumerla mi piace / e mi dà pace. / […] // Ed il mio tempo è un acino: acòlito / che, spremuto, fermenta / esalando nel mosto / l’azzardo della sua maturazione” (L’acòlito); ed ancora “Profumava il ginepro / le sue bacche di miele, / in agguato il ciliegio / – occhidineve – / d’oro le vele / tese dalla forsithia: / l’orizzonte un ricamo fiorito / di giunchiglie protese oltre la siepe, / verso il grano del campo: // Era tutto lì / il succo della vita, / nei semi di un’arancia già spremuta, / ….”. La poesia di Anna Maria è nutrita da una religiosità che si fonda su una profonda fede nella natura, nella vita. E la vita è per l’Autrice sacra in quanto comunque dono e proprio per questo guardata, affrontata, interrogata, accettata in tutto il suo carico di inevitabile sofferenza. Tornano alla mente le parole di un grande poeta del secolo scorso, a me particolarmente caro, Diego Valeri, che Luigi Baldacci definiva “il camaleonte della natura”. Da sempre convinto che la missione dell’arte è una sola, quella di “creare bellezza”, Valeri, per quanto refrattario a formule precostituite, in più occasioni ha, infatti, ribadito che a suo avviso la poesia è “espressione di sentimenti inspirati dalla contemplazione della multiforme realtà cosmica e umana, universale e individuale”; sentimenti che – osserva Valeri – il poeta esprime col verso, come l’artista, pittore o scultore che sia, col segno, compiendo ambedue la stessa operazione magica da cui balzano vivi i fantasmi, cioè la realtà della fantasia. Di questo interscambio continuo, fino a un fitto e misterioso intersecarsi, credo non sia azzardato ritenere maestra Anna Maria, che nello scrivere versi sembra trovare una sorta di zona di franchigia dove sfogare i sentimenti più strettamente personali, lungamente chiusi dentro; pare che il verso la sciolga da ogni segreto vincolo di silenzio, di pudore, scegliendo di “rendere in semplicità” le sue più segrete sensazioni, sempre peraltro consapevole che il giuoco non sta in noi ma noi facciamo parte di un giuoco imperscrutabile. Tale operazione, ma il termine per sua natura così asettico non è appropriato, è dall’Autrice condotta con la rara padronanza metrica opportunamente sottolineata da Luti in chiusura dell’introduzione al libro. Ma da dove nasce tale padronanza, che “tende costantemente a farsi canto e ritmo”? Quali sono le sue fondamenta? Se impossibile è prescindere dall’intensa ispirazione poetica di cui sin qui ho tentato di rendere ragione, è altrettanto indispensabile fare i conti con la profonda conoscenza che Anna Maria possiede dei classici, da Dante a Petrarca, su su fino ad esperienze poetiche a noi più vicine e non solo italiane. Lei per prima, così come in prove diverse del passato, ce ne dà scoperto indizio segnalando qua e là, in corso d’opera, a piè di testo, suggestioni che versi di altri autori le hanno procurato: Caproni, Pasolini, Sereni, Whitman… Una tradizione poetica da Anna Maria assimilata al meglio e metabolizzata fino a padroneggiarla con felice disinvoltura, senza rimanere sopraffatta da soverchie sovrastrutture intellettuali. Ne deriva quella che potremmo definire una classicità priva di paludamenti, personalmente interpretata, resa più ricca e rara da un uso peculiare del verbum sul quale, in chiusura, vorrei soffermarmi. Sempre consapevole del proprio fare, del proprio creare, Anna Maria non gioca mai, infatti, con le parole e tanto meno si rapporta loro con incedere casuale, bensì le utilizza come – è stato detto per altri – “le cose sante” della sua “comunione”. Non freddure, non calembours, non giochi di parole, quindi, ma intelligenti associazioni di termini tratti da registri diversi e parimenti dall’Autrice padroneggiati con naturale nonchalance. Magica e unica l’impronta così conferita al modus poëtandi della Guidi, che, “inesausta nocchiera / in tempeste di carta” (p. 160), non si sottrae mai dal concedere “ancora un giro alle parole / – voce della mia voce – ”. Un modus che nel tempo e nello spazio affonda le radici e insieme li supera in un intenso e fluido canto di memoria: “La mensa del poeta / è un’allucinazione di parole. // Cerimoniere dell’ombra / minestro la tavola // e in un cantuccio di silenzio aspetto / di cogliere abbagliato / il sale delle briciole”.
Data recensione: 01/11/2006
Testata Giornalistica: Il Portolano
Autore: ––