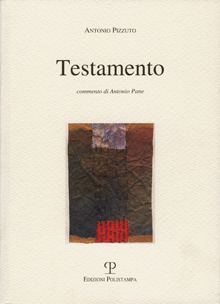Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Presso i tipi della fiorentina Polistampa è uscita, per le cure di Antonio Pane, una nuova edizione del libro che lo scrittore siciliano aveva pubblicato originariamente nel 1969 con Il Saggiatore. Un’opera di strenua prosa sperimentale che rappresenta un
Presso i tipi della fiorentina Polistampa è uscita, per le cure di Antonio Pane, una nuova edizione del libro che lo scrittore siciliano aveva pubblicato originariamente nel 1969 con Il Saggiatore. Un’opera di strenua prosa sperimentale che rappresenta un momento capitale nell’evoluzione stilistica dell’ex questore palermitano, con il passaggio dal regime delle ‘lasse’ inscritte in un unico disegno narrativo e dominate dall’imperfetto, tempo della duratività e soprattutto dell’indeterminazione, a quello delle ‘pagelle’, brevi componimenti in sé conclusi, caratterizzati dalla soppressione del verbo ai modi finiti, con relativa disgregazione di personaggi e vicende. «Se bisogna fare i conti col tempo — scriveva nel 1969 Walter Pedullà, cogliendo appieno la rivoluzione altrettanto linguistica che epistemologica operata con Testamento dal questore in quiescenza Antonio Pizzuto –, quale soluzione è migliore di una ‘durata’ la quale tutto faccia sembrare presente? Questo è il problema di Pizzuto: sfuggire alle presuntuose interpretazioni dello storicismo e rappresentare la vita quando è ancora ‘calda’, anzi come se si stesse svolgendo sotto gli occhi del lettore, che non sa mai dove lo porteranno le parole e che cosa gli faranno sentire, con quegli inattesi salti in situazioni non ‘richieste’, con quelle brusche e inizialmente sgradevoli e arbitrarie deviazioni di tema e di musica, con quei percorsi grigi o stonati che si aprono a vaste luminosità o a una splendida nota squillante o si imbucano nel vicolo cieco di uno scolorito o sfolgorante finale […]. Frutto maturo e talvolta anche troppo saporito di una civiltà letteraria, Testamento coincide con la struttura verosimilmente rivelata dalla cultura nata dalla crisi del realismo e nell’ambito di essa si dimostra di una ferrea coerenza, ma anche splendidamente ‘complice’ e, almeno nel senso in cui può esserlo un’opera d’arte, compromessa col suo destino. Può darsi tuttavia che per sopravvivere, la letteratura debba sacrificare una ‘forma’ come questa bellissima di Testamento e concedersi ai ‘barbari’ che innalzano il suo patibolo o a qualcuno che lavora con non minore ‘abilità’ letteraria, sull’opposto versante del Pizzuto».E così Gianfranco Contini accoglieva gli apografi che l’amico gli inviava durante la composizione: «Carissimo, la perfecta Nonna, rimbalzata dal Pian dei Giullari a queste Lepontine senza ecchimosi dal rimpallo, è sempre dolcissima come miele attico, liquida di olio soave, fragra di immagini lavande e cotogne, in cui ottocentescamente (quello è il mio secolo) mi rinvolvo. Se tutto Testamento è così, scrivi uno dei più libri della tua più mia più rea generazione»; «Carissimo e grandissimo, urrà urrà per la chiusa! Essa è festante, vitale ed euforica proprio come si addice a un testamento»; «il tuo poème en prose (se la definizione non ti offende) è stupendo; spero che ne seguiranno molti. Solo per non poterli trasformare da oro puro in oro monetato deploro di non detenere il “potere” culturale».In effetti Testamento (ora riproposto dalle edizioni Polistampa – Firenze 2009, pp. 312, € 23,00 – per le cure di Antonio Pane, a quarant’anni esatti dalla princeps, fortemente voluta da Alberto Mondadori) rappresenta un momento capitale nell’evoluzione stilistica del prosatore senza dubbio più sperimentalmente inventivo dell’altro secolo: il passaggio dal regime delle lasse («episodî» inscritti in un unico disegno narrativo – ancorché compiutamente fruibili nella loro essenza di blocchi compatti che un grande critico si spinse a definire monadi – e dominati dall’imperfetto, tempo della duratività e soprattutto dell’indeterminazione) a quello, appunto, delle pagelle, brevi componimenti in sé conclusi, caratterizzati dalla soppressione del verbo ai modi finiti, con relativa disgregazione di personaggi e vicende: i primi depressi a simulacri destituiti d’ogni potere sul piano tematico e agenti quasi in absentia (l’analisi psicologica è bandita insieme all’io giudicante), le seconde a illusorî motori d’intreccio (minimi, se non affatto assenti, i nuclei referenziali parafrasabili senza grave nocumento per i valori significativi) polverizzati da una visione subatomica postulante l’assoluto in ogni particella («L’osservatore non può essere continuo in un mondo di cose discontinue»), per una sempre più austera, rarefatta formalizzazione, cui coopera la diffusa omissione degli attualizzatori del nome, la seriazione paratattica sincopata dall’asindeto e, come avviene in poesia, l’orchestrazione della testura fonica, con uso in copia di parallelismi, ripercussioni timbriche, strutture iterative. Ma specialmente la compagine musiva, contesta d’infinite memorie variamente addentellate: impressionante lo spiegamento di citazioni prestigiose (non serbatoi di conoscenza ma pura esibizione di modelli o mirabili sintesi ritmiche), allomorfi arcaici, moduli sintattici classicheggianti, riscritture di cose proprie o altrui talmente dissimulate, trasfigurate o scarnificate da rendere estremamente ardua la ricerca di fonti e auctoritates. Una selva in cui Antonio Pane sa muoversi non solo con sorprendente agilità, ma con l’onestà e la cautela proprie dell’autentico ricercatore. Nel suo commento (ahimè collocato in fondo al volume e non a piè di pagina o in coda ad ogni componimento, infliggendo al lettore un ping pong oculare che rende ancor più gravoso il suo già ingrato ufficio) lo studioso siciliano scioglie con disinvoltura formidabili enigmi; illumina, grazie alla sua profonda conoscenza della biografia pizzutiana, luoghi a prima vista inestricabili; decifra neologismi (talora scambiando puri arcaismi per coniazioni originali, come ad esempio nel caso di arrosa: abbagli del tutto fisiologici in chi si cimenta con la prosa dello scrittore palermitano); si avventura nelle architetture sintattiche affrontando tutti i rischi dell’impresa (alle pp. 118 e 286 discorre di «tempi finiti», certo intendendo modi); propone decodifiche quasi sempre acute e suggestive del livello denotativo, pur nella consapevolezza che in Pizzuto il valore dei cosiddetti contenuti-significati rasenta lo zero, avendo la sua poetica il proprio centro vitale nella strutturazione dei dati formali.Un livre de chevet che nessun lettore di buona volontà si concederà il lusso d’ignorare.
Data recensione: 03/10/2009
Testata Giornalistica: Le Reti di Dedalus
Autore: Gualberto Alvino