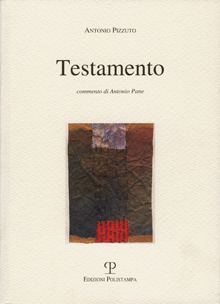Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Dopo aver letto, riletto e tradotto, almeno mentalmente, gli esametri omerici, Cesare Pavese, figlio di piccoli borghesi terrieri del Piemonte, maturò una salda convinzione, e la espresse in una formula che può apparire malinconica e negativa, laddove si
Dopo aver letto, riletto e tradotto, almeno mentalmente, gli esametri omerici, Cesare Pavese, figlio di piccoli borghesi terrieri del Piemonte, maturò una salda convinzione, e la espresse in una formula che può apparire malinconica e negativa, laddove si tratta di un referto tecnico: “Raccontare è monotono”. Poco tempo più tardi, Antonino Pizzuto, figlio dell’alta borghesia panormitana, dopo aver imparato a memoria l’Iliade e l’Odissea e averle salmodiate per la figlia piccolina Maria, si convinse che non era più ragionevole raccontare storie secondo un modulo fissato tra Sette e Ottocento: propose perciò una distinzione radicale tra il documentare del racconto tradizionale e il rappresentare melodico di una narrazione tutta da inventare. Poco più tardi ancora, un illustre docente tedesco, tra i primi vincitori stranieri di una cattedra al Collège de France (il suo nome è Harald Weinrich), ci spiegò che ogni discorso si compone di due elementi imprescindibili: l’uno che narra, l’altro che commenta.
Ed eccoci qui, all’inizio del terzo millennio, nella primavera 2009, di fronte a questo impeccabile volume delle edizioni Polistampa, fra le rarissime che sappiano ancora scegliere una carta, dei tipi, un formato, una grafica e siano disposte a rilegare l’insieme con ben cinque cuciture. Polistampa ci ripropone, quarant’anni esatti dopo una princeps anch’essa magnifica, la silloge dei venti testi che Antonio Pizzuto raggruppò, per Il Saggiatore di Alberto Mondadori, sotto il titolo Testamento. Nell’aprile del 1969 i risvolti della sopraccoperta recavano, in versione aggiornata, la nota stesa da Gianfranco Contini per celebrare l’ultimo scrittore accolto nella sua antologia Letteratura dell’Italia unita. Questa volta, invece, la fatica dell’autore che si snoda tra pagina 7 e pagina 107 è accompagnata da quella del commentatore, che spazia tra pagina 110 e 307. Storniamo il possibile equivoco: queste cifre non vogliono suggerire un dubbio sulla pertinenza delle proporzioni, e neppure sulla necessità del commento. Da moltissimi anni Antonio Pane svolge un lavoro eccezionale, per mole e qualità, sull’opera di Pizzuto: ricerca, descrizione e analisi dei manoscritti, indagine fattiva su tutti gli elementi del paratesto e pubblicazione commentata con rigore di lettura e di dati illuminanti, saggi elaborati con pazienza e acribia esemplari. Tutto il suo operato merita l’encomio senza riserve. Senza dire che quel commento è riportato, con saggia cautela, in una seconda parte del libro dove il lettore può decidere di non entrare mai. Però, fatti gli scongiuri contro quest’ultima eventualità, dobbiamo pure chiederci perché, dopo quarant’anni, uno dei testi più limpidi, solari, euforizzanti e, in breve, belli della letteratura italiana, debba uscire nel mondo con questa impressionante scorta documentaria. Qui torniamo alla rivoluzione poetica di Pizzuto, così descritta dall’agguerrita intelligenza di Contini: “Testamento consta di poemetti narrativi indipendenti ma idealmente connessi, muniti di titoli meramente tonali come in musica, sorta di composizioni di oggetti corrispondenti alla fenomenicità della memoria”. L’osservazione dev’essere affinata rileggendo uno dei testi più noti di Barthes, pubblicato anch’esso, guarda caso, nella primavera 1968: L’effetto di realtà. Il critico francese se la prendeva allora con l’ottusa borghesia trionfante di fine Ottocento, che esigeva di riscuotere gli interessi referenziali e semantici dell’investimento fatto con gli occhi, il cervello e la dottrina (quando c’erano) nel decifrare i segni sulla carta. Ora, non è detto che occorra aver fatto turismo nella parte nordoccidentale della Sicilia, conoscere le origini del ramo materno dell’autore e infine sapere a memoria tutte le ricette dei fegatini di pollo, per leggere perfettamente il meraviglioso incipit del primo testo della silloge, Nonna, che suona come un lungo verso anomalo composto di un dattilo seguito da quattro anapesti: “Erice, odoranti di salvia i suoi paradisi”. Se la scrittura di Pizzuto ci appare catafratta nella sua perfezione (lo diceva Contini, ma a mo’ di elogio), è perché non siamo più avvezzi a sentire – in tutti i sensi – il canto dei testi, mentre siamo nevroticamente golosi di significati, scenari, azioni, discorsi compiuti, lezioni e, infine, conclusioni. Soprattutto, non ammettiamo di poter non capire.
Pizzuto, alla fine del suo iter poetico, era come lo Hugo di Cocteau: era un pazzo che credeva di essere Pizzuto, era cioè qualcuno che sapeva tessere un discorso lirico e insieme universale, esteticamente armonico e gnoseologicamente intenso, un discorso magico e totale capace di suscitare nel lettore comune una forma di orror sacro. Testamento materializza questa pazzia sintattica che ci parla di noi stessi e di una nostra totalità: che ci spaventa quando dovrebbe allettarci, affascinarci, esaltarci e infine rappacificarci con questo intimo movimento musicale, che ha il suono inconfondibile della coscienza umana.
Ed eccoci qui, all’inizio del terzo millennio, nella primavera 2009, di fronte a questo impeccabile volume delle edizioni Polistampa, fra le rarissime che sappiano ancora scegliere una carta, dei tipi, un formato, una grafica e siano disposte a rilegare l’insieme con ben cinque cuciture. Polistampa ci ripropone, quarant’anni esatti dopo una princeps anch’essa magnifica, la silloge dei venti testi che Antonio Pizzuto raggruppò, per Il Saggiatore di Alberto Mondadori, sotto il titolo Testamento. Nell’aprile del 1969 i risvolti della sopraccoperta recavano, in versione aggiornata, la nota stesa da Gianfranco Contini per celebrare l’ultimo scrittore accolto nella sua antologia Letteratura dell’Italia unita. Questa volta, invece, la fatica dell’autore che si snoda tra pagina 7 e pagina 107 è accompagnata da quella del commentatore, che spazia tra pagina 110 e 307. Storniamo il possibile equivoco: queste cifre non vogliono suggerire un dubbio sulla pertinenza delle proporzioni, e neppure sulla necessità del commento. Da moltissimi anni Antonio Pane svolge un lavoro eccezionale, per mole e qualità, sull’opera di Pizzuto: ricerca, descrizione e analisi dei manoscritti, indagine fattiva su tutti gli elementi del paratesto e pubblicazione commentata con rigore di lettura e di dati illuminanti, saggi elaborati con pazienza e acribia esemplari. Tutto il suo operato merita l’encomio senza riserve. Senza dire che quel commento è riportato, con saggia cautela, in una seconda parte del libro dove il lettore può decidere di non entrare mai. Però, fatti gli scongiuri contro quest’ultima eventualità, dobbiamo pure chiederci perché, dopo quarant’anni, uno dei testi più limpidi, solari, euforizzanti e, in breve, belli della letteratura italiana, debba uscire nel mondo con questa impressionante scorta documentaria. Qui torniamo alla rivoluzione poetica di Pizzuto, così descritta dall’agguerrita intelligenza di Contini: “Testamento consta di poemetti narrativi indipendenti ma idealmente connessi, muniti di titoli meramente tonali come in musica, sorta di composizioni di oggetti corrispondenti alla fenomenicità della memoria”. L’osservazione dev’essere affinata rileggendo uno dei testi più noti di Barthes, pubblicato anch’esso, guarda caso, nella primavera 1968: L’effetto di realtà. Il critico francese se la prendeva allora con l’ottusa borghesia trionfante di fine Ottocento, che esigeva di riscuotere gli interessi referenziali e semantici dell’investimento fatto con gli occhi, il cervello e la dottrina (quando c’erano) nel decifrare i segni sulla carta. Ora, non è detto che occorra aver fatto turismo nella parte nordoccidentale della Sicilia, conoscere le origini del ramo materno dell’autore e infine sapere a memoria tutte le ricette dei fegatini di pollo, per leggere perfettamente il meraviglioso incipit del primo testo della silloge, Nonna, che suona come un lungo verso anomalo composto di un dattilo seguito da quattro anapesti: “Erice, odoranti di salvia i suoi paradisi”. Se la scrittura di Pizzuto ci appare catafratta nella sua perfezione (lo diceva Contini, ma a mo’ di elogio), è perché non siamo più avvezzi a sentire – in tutti i sensi – il canto dei testi, mentre siamo nevroticamente golosi di significati, scenari, azioni, discorsi compiuti, lezioni e, infine, conclusioni. Soprattutto, non ammettiamo di poter non capire.
Pizzuto, alla fine del suo iter poetico, era come lo Hugo di Cocteau: era un pazzo che credeva di essere Pizzuto, era cioè qualcuno che sapeva tessere un discorso lirico e insieme universale, esteticamente armonico e gnoseologicamente intenso, un discorso magico e totale capace di suscitare nel lettore comune una forma di orror sacro. Testamento materializza questa pazzia sintattica che ci parla di noi stessi e di una nostra totalità: che ci spaventa quando dovrebbe allettarci, affascinarci, esaltarci e infine rappacificarci con questo intimo movimento musicale, che ha il suono inconfondibile della coscienza umana.
Data recensione: 01/07/2009
Testata Giornalistica: L’Indice dei Libri del Mese
Autore: Denis Ferraris