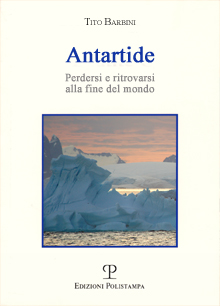Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
È stato osservato recentemente che la narrativa italiana contemporanea soffre di un male diffuso, cioè il difetto di esperienza. Non tecnica, non di scrittura nel senso stilistico; l’inesperienza riguarda proprio il limite alla
È stato osservato recentemente che la narrativa italiana contemporanea soffre di un male diffuso, cioè il difetto di esperienza. Non tecnica, non di scrittura nel senso stilistico; l’inesperienza riguarda proprio il limite alla conoscenza del mondo, della storia e degli effetti che i luoghi, l’epoca e le grandi dinamiche sociali e culturali hanno sull’uomo. La maggior parte degli scrittori si concentra sulla speculazione esistenziale, senza attingere all’esperienza vitale. Da un lato, questa è la conseguenza di un processo che ha un lungo corso nel Novecento, cioè la rarefazione e la deriva del soggetto, dell’“autorità dell’autore” e delle sue prospettive sulla realtà che egli narra, sulla stessa possibilità – direi – di narrare e interpretare la realtà. Dall’altro, l’indebolimento dell’esperienza è un fenomeno che ha raggiunto il culmine nei nostri anni e alle nostre latitudini, per cui l’esperienza è indiretta, non ci coinvolge fisicamente ma solo attraverso il filtro dei mezzi di comunicazione, della virtualità. Antartide di Tito Barbini è invece un libro sulla riconquista dell’esperienza (che non a caso è una delle parole ricorrenti, un Leitmotiv), o sull’esperienza ritrovata se vogliamo riprendere in chiave proustiana il sottotitolo di questo diario: “perdersi e ritrovarsi alla fine del mondo”. Lo si può dire per tutta la vera letteratura di viaggio, poiché probabilmente, quando gli eventi accadono altrove (la guerra, le rivoluzioni) o sugli schermi e quando l’impegno affievolisce, una delle poche chances di intervento, una delle poche avventure conoscitive è quella di portarsi letteralmente ai confini del mondo. “La globalizzazione – scrive Barbini – avrà ridotto le distanze, appiattito le differenze, sottratto fascino a tanti spostamenti e banalizzato lo spirito di avventura, ma il viaggio è sempre un prologo al cambiamento” (p. 15). Ciò a maggior ragione se la destinazione è l’Antartide: un continente vuoto ed enorme, bianco come una pagina pulita sulla quale riscrivere la propria storia alla luce di un’esperienza estrema, riflettendo sulla propria collocazione nel mondo e andando quindi in cerca delle coordinate di quel mondo, senza fermarsi a registrare soltanto le proprie emozioni. “Tutto è vero, tutto è autentico”, pensa il protagonista a bordo della nave rompighiaccio che lo porta in Antartide. In questo senso, le foto che corredano il volume, oltre che un ornamento (e un risparmio su tante descrizioni verbali inevitabilmente superate dalla realtà che l’immagine ritaglia) sono come la certificazione di questa autenticità: lo scrittore era lì sul serio, c’è andato davvero. Ho parlato di letteratura di viaggio, perché il libro, nonostante sia anche il giornale di bordo di un passeggero sulla rotta antartica, non si esaurisce nella cronaca, nel resoconto; nella sua costruzione si riconoscono da un lato numerose tracce lasciate dalle letture di altri autori (Francisco Coloane, il Melville di Moby Dick, lo stesso Proust), dall’altro si individua una linea di sviluppo classica del romanzo moderno, l’itinerario che conduce a una formazione, all’acquisizione di una consapevolezza nuova e più autentica su se stessi e sul mondo. Si prenda il primo capitolo, che è un preambolo al viaggio: lì il protagonista e narratore è ancora inesperto, concepisce l’Antartide come una terra sognata e lontana, così lontana – scrive Barbini – “da smarrirsi in un’altra vita”. Nelle prime pagine, il protagonista si rappresenta nell’atto romantico di contemplare le stelle, la Croce del sud, aspirando a raggiungere un luogo ideale e indistinto. Nel prosieguo, capitolo dopo capitolo, l’esperienza prevale sull’immaginazione, la concretezza sulla vaghezza: insomma, se all’inizio il personaggio assomiglia al pastore errante leopardiano, a poco a poco si trasforma in Robinson Crusoe, trascinando nelle pagine del libro la conoscenza fisica delle cose (attinta non solo con la vista, ma con tutti i sensi), oltre alla contemplazione mentale dei loro contorni immaginari. In tal senso, con tutta la forza e l’inattualità che questo comporta, si può dire che il Tito che parla in Antartide è un eroe moderno. Ci sono altre tappe di una formazione per così dire romanzesca: il distacco dagli affetti, la temperanza imposta alle passioni giovanili, l’immedesimazione nel ruolo del padre, l’emulazione dei modelli. E poi, è ovvio, il viaggio in sé. Qual è la differenza con il viaggio di formazione e iniziazione narrato in molti romanzi moderni? Più d’una, ma la principale direi che riguarda l’età del protagonista. Non è in questione l’ingresso nell’età adulta, ma la raggiunta pienezza di un’età compiuta; ciò non toglie che il viaggio sia legato a un inizio, che qui coincide con il giorno “della seconda nascita”, dopo l’infarto che ha colpito l’autore nel 1999. La circostanza permette al narratore si affiancare al piano del presente in cui viene compiuto il viaggio, quello del passato in cui l’esperienza in atto rimanda alle esperienze ricordate, dell’infanzia, della giovinezza, della maturità: “Ricordare il passato e immaginare il futuro, del resto, sono esercizi della mente che stanno bene insieme” (p. 79). “Comunque – prosegue Barbini – ho letto […] che scienziati e psicologi, dopo essersi finora concentrati su un solo aspetto del viaggio mentale nel tempo, quello che ci permette di ricordare, hanno dimostrato che esiste un’altra metà del viaggio, quella che ci consente di proiettarsi nel futuro, di concepirlo ancora prima di progettarlo.” Il protagonista ha con sé durante il viaggio il testo di una conferenza di Martin Heidegger, che precede il suo capolavoro Essere e tempo; nella conferenza, intitolata Il concetto di tempo (1924) e pubblicata in un volumetto di Adelphi, Heidegger scrive che “non c’è un tempo assoluto e nemmeno una sincronicità assoluta”, ma io sono il tempo, ne sono la misura in quanto sento me stesso nell’esistenza, non perché misuro gli eventi esterni con strumenti oggettivi come un orologio. È la concezione del tempo intorno a cui Barbini costruisce i piani della sua narrazione; rinnova così anche la tradizione del viaggiatore che fa esperienza del luogo esplorato sì con i propri sensi fisici e ma anche con i sensi intellettuali di un autore caro: è il modello di Petrarca che sale sul Monte Ventoso con le Confessioni di Agostino donategli da Dionigi da San Sepolcro.Questo, oltre a rimandarci al viaggio prefigurato nel primo capitolo, spiega come la dislocazione nello spazio diventi anche un’erranza nel tempo. Del resto, Barbini scrive che accanto alla gioia di partire c’è “quella di errare per il mondo”, dove ‘errare’ è “un modo di viaggiare che si alimenta di digressioni e imprevisti, deviazioni e voglie”. La costruzione del libro, che alterna il racconto al ricordo, riflette lo stesso principio che ispira il viaggio digressivo cui tende il narratore. Ho parlato di due piani temporali e ho citato, sulla scorta dell’autore, il nome di Proust. Come ognuno sa, l’ultima parte della grande Recherche proustiana è intitolata Il tempo ritrovato. Io credo che Barbini abbia voluto metterci di fronte a una sua forma di ritrovamento del tempo. “Viaggio per riannodare i fili di un discorso che non si è mai interrotto e che forse ha bisogno solo di essere completato, sempre che questo sia mai possibile” (p. 47). Riannodare i fili, dice Barbini, cioè restituire un senso all’esperienza passata alla luce di quella presente, e viceversa, dando al tempo che è trascorso un orientamento, la possibilità di giungere coerentemente a un approdo (lo sbarco in Antartide è anche una metafora di tale approdo). Quindi riannodare i fili vuol dire, alla lettera, congiungere ciò che si è nel presente con ciò si è stati nel passato; da qui prende avvio una ricerca delle motivazioni. La passione per il viaggio deriva dal mestiere itinerante dei genitori; il nome – Tito – attinge alla storia del Novecento, così come Gimma – il nome della sorella – discende dalla località africana vista dal padre durante la sua missione coloniale. Del resto, sull’etimologia dei nomi e sull’origine delle espressioni, Barbini si sofferma più d’una volta e si capisce bene che non lo fa con l’intento aneddotico di una guida turistica, ma per passione e curiosità (nel senso etimologico: chiedersi il perché – in latino cur – delle cose). In particolare, la curiosità si appunta sui nomi antifrastici, che designano i fenomeni attribuendo loro caratteristiche opposte alla loro reale sostanza: l’Oceano Pacifico è tutto tranne che pacifico; la Terra del Fuoco è ghiacciata più che infuocata; il tempestoso Capo Horn prende il nome da una placida cittadina olandese. Direi che questo è il versante linguistico dell’esperienza: quando si è davanti alla realtà, quando la si vive con tutti i sensi e con tutto il corpo, l’apparenza nominalistica delle cose rivela la sua fallacia. Eppure, anche la superficie dei nomi ha una sua profondità storica (la Terra del Fuoco era in origine Terra del Fumo: una deduzione errata è alla base del nome attuale), è il frutto di un tempo che si stratifica dando una prospettiva, una profondità anche alle contraddizioni: in breve, è il tempo che si fa Storia. L’incontro con Serghei, il marinaio della nave rompighiaccio, esemplifica questo processo. Serghei si era imbarcato sulla nave quando questa era ancora parte della flotta sovietica; dissoltasi l’Urss, la nave era stata acquistata da una compagnia sudamericana che, dopo averne adattato l’interno per le nuove mansioni, la usava per trasportare i viaggiatori diretti verso l’Antartide. I nuovi proprietari avevano però assunto in blocco, insieme alla nave, tutto il suo antico equipaggio dotato delle competenze migliori per condurla. Ed ecco che Serghei, ferito nell’orgoglio per non poter più appartenere alla gloriosa marina sovietica, ha assunto il ruolo del traghettatore: “Ironia della storia. Coincidenze della storia, con i loro indubbi significati simbolici. A bordo di questo rompighiaccio sovietico non ci sono solo una ventina di fortunati europei, canadesi e americani. Per la prima volta nella storia di questi viaggi antartici si sono imbarcati anche alcuni cittadini della Repubblica Popolare Cinese. […] Appartengono senz’altro alla categoria dei “ricchi comunisti”: uomini che devono la loro fortuna a un disinvolto affarismo ma anche alla loro fedeltà in un regime che ancora si proclama socialista” (p. 125).L’incontro (per inciso, un altro grande tema romanzesco), di Tito e Serghei segna l’ingresso definitivo della materia politica nelle pagine del romanzo. Materia che tanta parte ha avuto nell’esperienza dell’autore-protagonista e che qui, come altri passaggi che hanno scandito la biografia di Barbini, viene spogliata del valore che ha avuto nel passato per l’individuo diventando una prospettiva da rinnovare per tutti nel futuro. [Leggere pp.103-105]Non si tratta né di nostalgia né di utopia: lo impediscono la semplificazione e la grandezza, la riduzione all’essenziale che l’Antartide impone all’esperienza. Ma, come vediamo accadere anche a esponenti della politica internazionale, l’impegno si trasforma nella condivisione di un valore fondamentale. La battaglia per un modello di società si evolve nella consapevolezza che ogni tutela è irrealizzabile senza assicurare un presupposto: “Il riscaldamento del pianeta e lo scioglimento dei ghiacci da una parte, l’assalto dell’uomo con la ricerca del profitto dall’altra, possono rompere l’incantesimo. La sfida che abbiamo davanti è enorme ma ognuno di noi che ha amato e ama quest’ambiente così estremo può fare qualcosa. L’obiettivo su cui stanno lavorando scienziati ed esploratori è quello di creare il più grande parco del mondo. Un parco di ghiacci grande come un continente che non sarà mai spartito e usato, perché appartiene al futuro nostro e dei nostri nipoti.” (p. 172). Con queste parole si chiude il libro, con una speranza ecologica che, sfidando la retorica, punta all’essenza, alla condivisione (si noti che Barbini usa qui, come spesso nel suo libro, la prima persona plurale, superando la dizione interiore, il movimento lirico dei pensieri per dare invece il senso di un discorso che sia comune a tutti). Auspica la continuazione del futuro nostro in quello dei nostri eredi: il modo più autentico di ‘ritrovarsi’, di ‘riannodare i fili’ tra il tempo vissuto e quello da vivere.
Data recensione: 18/03/2008
Autore: Niccolò Scaffai